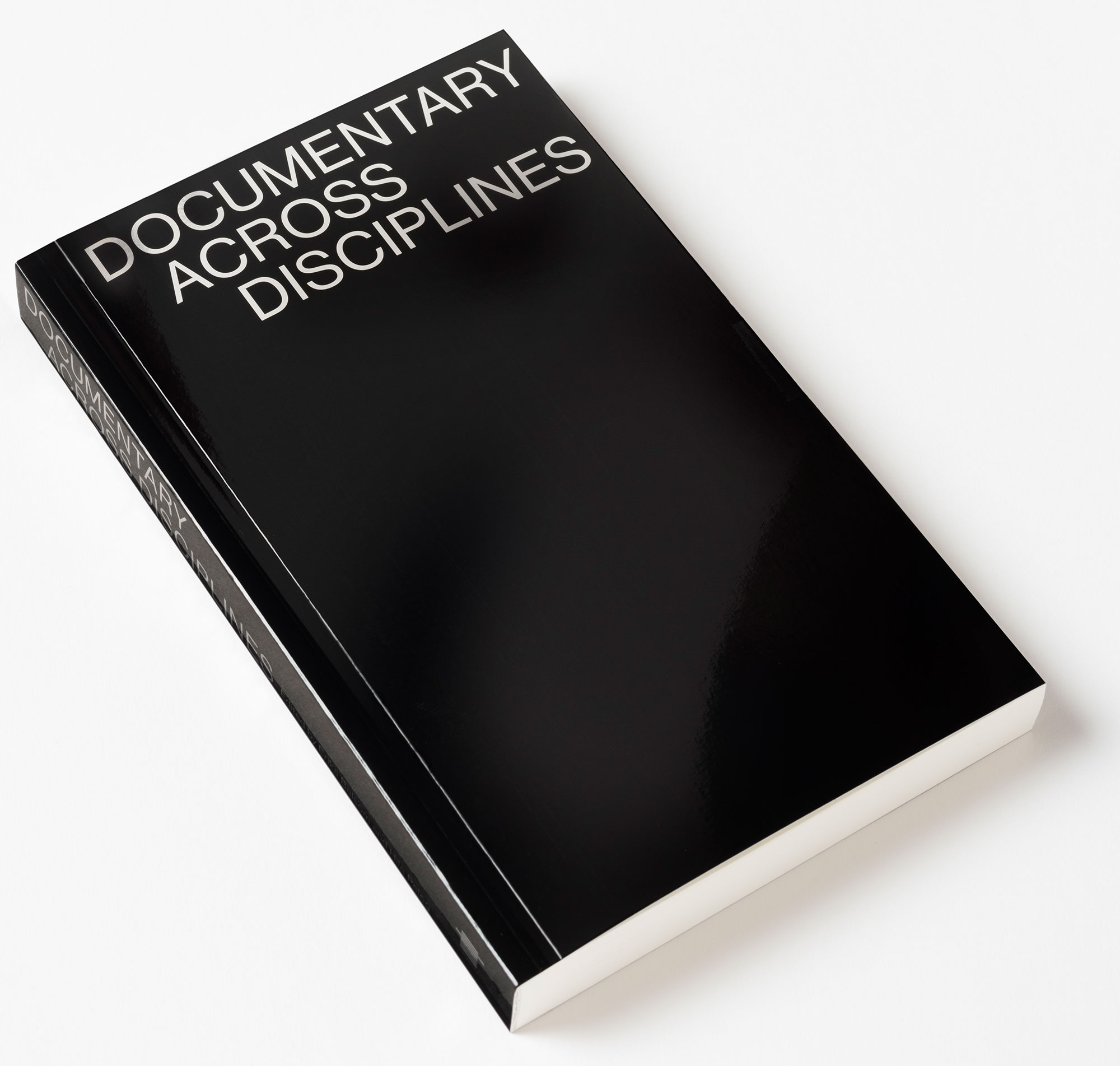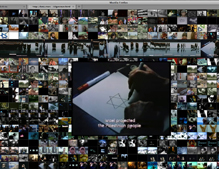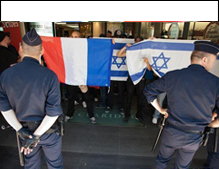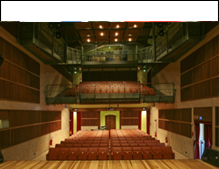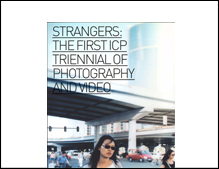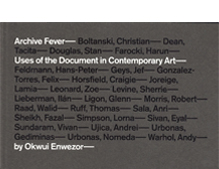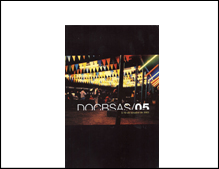-
Proposal for a visual media exhibition
with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -
Get my films
Buy DVDs online at www.momento-films.com -
IZKOR
slaves of memory
Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -
Common Archive Palestine 1948
web based cross-reference archive and production platform
www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -
Montage Interdit [forbidden editing]
With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -
Route 181
fragments of a journay in Palestine-Israel
Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST
-
The Specialist
portrait of a modern criminal
Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -
Jaffa
the orange's clockwork
Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST
-
Montage Interdit
www.montageinterdit.net
Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress
-
Common State
potential conversation [1]
Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -
Towards a common archive
testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine
Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013
-
I Love You All
Aus Liebe Zum Volk
Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST
reviews
Na(rra)zioni parallele by Simon Levis Sullam (Il Manifesto)
13.07.2004
Saggi, libri di storia, ma anche manuali scolastici e documentari israeliani e palestinesi cercano di ripensare al passato e al futuro del conflitto mediorientale oltre le tradizionali visioni contrapposte. Rimettendo in discussione le fonti utilizzate, i soggetti presi in considerazione, le prospettive convenzionali e rivedendo ciascuno i propri miti nazionalisti di fondazione.
«Le comunità [nazionali] devono essere distinte non dalla loro falsità/genuinità, ma dallo stile in cui esse sono immaginate», ha scritto lo studioso dei nazionalismi Benedict Anderson, secondo cui le nazioni sono «comunità immaginate» (è il titolo del suo celebre libro, pubblicato da manifestolibri nel 1991), cioè il frutto di costruzioni simboliche collettive. E il critico letterario Homi Bhabha, nel volume “Nation and Narration” (Routledge 1990), ha sottolineato che le nazioni esistono in quanto si diano narrazioni che le raccontino, che ne illustrino le origini, che ne definiscano una storia.
In effetti la prima età dei nazionalismi europei ha prodotto, con l'invenzione o la riaffermazione di cause nazionali e stati nazione, non solo movimenti politici patriottici, ma letterature e arti nazionali con stili specifici e, fin dal principio, storici e scrittori che hanno raccontato la genesi e illustrato le gesta delle rispettive nazioni. Si pensi al Thierry delle “Lettere sulla storia di Francia” (1827); o al nostro Manzoni col “Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia” (1822). Si potrebbe osservare, inoltre, che le comunità nazionali sono indotte a ripensare la propria storia e a reinterpretare il proprio destino, tanto più in momenti di crisi o di trasformazione radicale. Si pensi, per limitarsi al caso italiano, alle narrazioni parallele e contrapposte della nostra storia nazionale nate all'indomani del consolidarsi del regime fascista: nella versione liberale di Benedetto Croce, in quella nazional-fascista di Gioacchino Volpe, o in quella marxista che si trova in nuce nei “Quaderni del carcere” di Gramsci. Ma anche alla funzione che ebbe, nei mesi di incubazione della Resistenza, “Pensiero e azione nel Risorgimento” di Luigi Salvatorelli, pubblicato nella primavera del 1943.
Il problema delle narrazioni nazionali sta al centro o sullo sfondo di diversi contributi recenti sulla storia e l'attualità del conflitto israelo-palestinese.
È posto in modo concreto e drammatico dal documentario Route 181. Frammenti di un viaggio in Palestina-Israele, pubblicato in DVD da Bollati Boringhieri (4 voll., 49 euro), di Eyal Sivan e Michel Khleifi, due registi, uno israeliano e uno palestinese, che percorrono Palestina e Israele con una telecamera sulla spalla, intervistando tutti quelli che incontrano sul loro cammino, moltiplicando così i punti di vista e le narrazioni sul conflitto mediorientale, le sue origini e prospettive, reinterpretate in un road-movie in presa diretta.
È messo a frutto nel prezioso manuale di storia, nato per le scuole israeliane e palestinesi, grazie al lavoro di un gruppo di insegnanti delle due parti, La storia dell'altro. Israeliani e palestinesi (cooperativa editrice Una città, 139 pp., 12 euro) [vedi più sotto], in cui la storia della regione è raccontata secondo due versioni, palestinese e israeliana, messe a confronto su due colonne — separate nell'edizione originale bilingue da una terza, bianca, in cui gli studenti possono scrivere la «loro» storia: che sia una versione originale o un tentativo di conciliazione delle due.
Ma un tentativo di scalzare le narrazioni tradizionali della storia del Medioriente, e in particolare la —a lungo prevalente, per quanto variamente articolata— storiografiasionista, è quello autorevole e originale di Ilan Pappe, docente di storia all'Università di Haifa e uno dei più impegnati e coraggiosi «nuovi storici» israeliani, nel suo recente A History of Modern Palestine. One Land, Two Peoples, pubblicato da Cambridge University Press (e in corso di traduzione in Italia da Einaudi). Come spiega provocatoriamente nell'introduzione al suo libro, Pappe intende «"bi-nazionalizzare" la storia e perfino "de-nazionalizzarla", per allentare la ferma presa del nazionalismo sulla storiografia»: cioè da un lato porre a confronto le due versioni nazionali della storia di Israele-Palestina, dall'altro rimettere in discussione o evitare gli schemi tipici delle storiografie nazionali: mitologici, etnocentrici, teleologici. Ma nel suo approccio, Pappe aspira anche a liberarsi dai preconcetti che provengono dalle teorie occidentali della modernizzazione, dall'elitismo della storia politica tradizionale, dalle definizioni e categorie a priori che i diversi gruppi nazionali, religiosi, etnici o clanici propongono o impongono nelle loro narrazioni contrapposte. Inoltre lo storico di Haifa ha scelto esplicitamente di adottare, anche sulla scia dei «subaltern studies» postcoloniali (ispirati in origine dal nostro Gramsci), un approccio soggettivo che assume innanzitutto il punto di vista palestinese, benché l'autore sia israeliano, che «ammette compassione per il colonizzato non il colonizzatore; simpatizza per l'occupato non l'occupante; sta dalla parte dei lavoratori non dei padroni». La narrazione storica di Pappe «spesso ma non sempre parteggia con gli sconfitti piuttosto che coi vincitori».
Il problema delle narrazioni nazionali parallele del conflitto mediorientale è, infine, esplicitamente tematizzato e teorizzato nel volume a cura dello stesso Pappe e del sociologo palestinese Jamil Hillal, Parlare con il nemico. Narrazioni palestinesi e israeliane a confronto (edizione italiana a cura di Maria Nadotti, Bollati Boringhieri, pp. 299, 24 euro
Si tratta di una raccolta di saggi di studiosi israeliani e palestinesi che cercano di ripensare alla storia di Israele-Palestina oltre le concezioni tradizionali e le visioni contrapposte, rimettendo anche qui in discussione le fonti utilizzate, le prospettive storiografiche e politiche convenzionali, e naturalmente rivedendo ciascuno i propri, congenitamente irreconciliabili, miti di fondazione. Sforzo comune, teorizzato dai curatori, è quello di costruire delle «narrazioni-ponte», cioè «il consapevole sforzo storiografico compiuto da storici appartenenti a società dilaniate da prolungati conflitti interni ed esterni per andare al di là delle narrazioni e storiografie in lotta tra loro». Esistono una serie di precondizioni che possono rendere possibile questo tipo di operazione storiografica. La prima, che ha dato il via in Israele a un vero e proprio movimento intellettuale, è quella che ha visto innanzitutto i cosiddetti «nuovi storici» israeliani, che Pappe definisce «post-sionisti», iniziare a riscrivere la storia del 1948, cioè della nascita dello stato d'Israele, oltre la leggenda e l'oleografia, riconoscendo —anche grazie all'utilizzo di documenti ufficiali divenuti finalmente consultabili— che essa segnò anche «l'espulsione di massa» di palestinesi, «con la conseguente distruzione di circa quattrocento villaggi e il massacro di alcune migliaia di palestinesi». Vi sono poi una serie di ridefinizioni della propria posizione di studio e osservazione, che riconoscano l'influenza «della propria politica identitaria sulla ricerca storica», con cui —citiamo sempre i curatori del volume— «la parte più forte ed egemone rinuncia al proprio potere di dominio sulla conoscenza, mentre la parte subalterna e più debole riduce il proprio ossequio nei confronti della propria ideologica narrazione storica». Vengono, infine, messi da parte la storia elitaria e nazionalista, e posti al centro della narrazione storica nuovi soggetti, in precedenza marginalizzati, come le donne, i lavoratori e i contadini, che costituivano tra l'altro una parte assolutamente preponderante della popolazione coinvolta da entrambe le parti.
I risultati di questi nuovi approcci segnano effettivamente l'avvio di nuove letture e interpretazioni della storia del Medioriente e dei conflitti che lo insanguinano da almeno oltre mezzo secolo, ma in realtà nel corso di tutto il Novecento — sebbene molta strada vi sia ancora da percorrere per affinare queste prospettive, moltiplicare i punti di osservazione, coordinarli e integrarli o almeno metterli in comunicazione, a costruire un nuovo quadro e nuove narrazioni, che continueranno a loro volta a trasformarsi nel tempo, com'è tipico di ogni storiografia viva e operante, tanto più attorno vicende così conflittuali e ancora irrisolte. Il ricorso alla storia orale, e in particolare al racconto delle donne, ad esempio, come nel saggio dell'antropologa palestinese Rema Hammami dedicato a Genere, Nakba e nazione, offre un'inedita, più ricca e drammatica visione della «catastrofe» palestinese (Nakba), cioè la nascita dello Stato ebraico coi conflitti che la precedettero, documentabili dal punto di vista palestinese soprattutto attraverso le memorie e i racconti personali, tipici o, meglio, addirittura irrinunciabili per la storia di una società all'epoca in maggioranza non ancora alfabetizzata. La riflessione dello storico palestinese Issam Nassar sull'«identità ambivalente» del Nazionalismo palestinese, mostra invece, d'altra parte, che la cronologia, l'evoluzione e la definizione stessa del nazionalismo palestinese non solo non siano scontate, ma siano particolarmente controverse e sfuggenti nella stessa storiografia araba e palestinese. Il movimento può essere infatti ricondotto nell'alveo più ampio del nazionalismo arabo o pan-arabo, come avveniva prevalentemente al discorso politico palestinese negli anni Sessanta; oppure datato alle prime espressioni politiche e giornalistiche che si riferiscano precisamente alla Palestina come entità politica distinta nei primi decenni del Novecento. La storia nazionale palestinese va del resto strettamente legata a quella di altre realtà a cui essa reagiva e con cui geneticamente interagiva: cioè quella ebraica, ma anche quella delle potenze mandatarie, e prima ancora dell'impero ottomano, o degli antichi o nascenti stati arabi. L'identità o le identità palestinesi, d'altra parte, in particolare al principio del Novecento, non erano prevalentemente di tipo nazionale, ma rispecchiavano piuttosto —secondo Nassar— «affiliazioni locali, regionali e religiose». E del resto la stessa identità ebraica o quella sionista, spesso supposte anche in questi contributi come monolitiche, vanno scisse e articolate nelle loro molte manifestazioni e nei loro diversi orientamenti, fedeltà, progetti, differenziati e talora antitetici, o persino contrapposti — esattamente come nelle attuali società israeliana e palestinese, che ancora oggi si confrontano e si scontrano anche al proprio interno.
Anche la parte israeliana di questo volume naturalmente ripensa e ridefinisce se stessa e i propri miti fondatori. Quelli del 1948 e della nascita dello Stato, che non furono soltanto una «guerra di indipendenza» come a lungo sono stati descritti in chiave risorgimentale; quelli della nascita e della vita di una democrazia, che è in effetti una «etnocrazia» o, nel migliore dei casi, una «democrazia etnica»; quelli che riguardano il trauma originario della Shoah, il suo spazio ed il suo «uso pubblico» nella politica e nella società israeliana. Quelli, infine, di una società sotto assedio, in cui una parte decide tragicamente di eliminare il proprio capo, infrangendo il tabu originario e ogni principio di convivenza civile, coll'uccisione del premier Yitzhak Rabin.
Un nuovo presupposto che dovrebbe riguardare entrambe le narrazioni, israeliana e palestinese, ed è proposto da uno specifico contributo dello stesso Ilan Pappe, è infine l'abbandono della propria «auto-vittimizzazione» e il riconoscimento di una «vittima» anche nell'«altro», e rispettivamente dell'esistenza di un «carnefice», che si tratti di se stessi o di altri. Per entrambe le parti è difficile riconoscere l'altra, o anche l'altra, come «comunità sofferente». D'altra parte, nota Pappe, «la negazione dell'altro, della sua sofferenza e delle sue sventure, è un elemento fondante per modellare le identità nazionali»; e nel caso di Israele e Palestina, «il controllo della memoria collettiva di entrambi i gruppi è parte della violenta lotta esistenziale per la sopravvivenza nazionale» — in una medesima terra, attorno ai medesimi simboli, aggiungiamo. Eppure, come spiegò lo storico francese Ernest Renan, nella sua celebre conferenza alla Sorbona del 1882, “Che cos'è una nazione?”: «l'essenza di una nazione sta nel fatto che tutti i suoi individui condividano un patrimonio comune, ma anche nel fatto che tutti abbiano dimenticato molte altre cose». E Renan sostenne anche, in quella occasione, che la nazione è il frutto di un «plebiscito quotidiano».
Non si può evidentemente pretendere che israeliani e palestinesi riconoscano plebiscitariamente l'esistenza di un'unica nazione: prospettiva irrealistica e ormai (o fin dall'inizio) antistorica; né che essi costruiscano il proprio futuro sull'oblio delle sofferenze inflitte reciprocamente o subite in passato da altri. D'altra parte pare anche evidente che la costruzione di nuove narrazioni parallele, incrociate, intrecciate, relativizzate e contestualizzate, non sia solo o affatto un'operazione accademica e intellettualistica, ma appaia sempre più come un requisito fondamentale, un'azione culturale e anche politica, o etico-politica, preliminare per guardare assieme con maggiore equilibrio e speranza, ma anche maggiore conoscenza di sé e dell'altro, al futuro della regione. Facendo quindi necessariamente passare il proprio futuro —com'è proprio di ogni nazione, e persino di ogni individuo— attraverso un ripensamento profondo, una nuova consapevolezza e interpretazione, e nuove narrazioni, della propria storia.
«Le comunità [nazionali] devono essere distinte non dalla loro falsità/genuinità, ma dallo stile in cui esse sono immaginate», ha scritto lo studioso dei nazionalismi Benedict Anderson, secondo cui le nazioni sono «comunità immaginate» (è il titolo del suo celebre libro, pubblicato da manifestolibri nel 1991), cioè il frutto di costruzioni simboliche collettive. E il critico letterario Homi Bhabha, nel volume “Nation and Narration” (Routledge 1990), ha sottolineato che le nazioni esistono in quanto si diano narrazioni che le raccontino, che ne illustrino le origini, che ne definiscano una storia.
In effetti la prima età dei nazionalismi europei ha prodotto, con l'invenzione o la riaffermazione di cause nazionali e stati nazione, non solo movimenti politici patriottici, ma letterature e arti nazionali con stili specifici e, fin dal principio, storici e scrittori che hanno raccontato la genesi e illustrato le gesta delle rispettive nazioni. Si pensi al Thierry delle “Lettere sulla storia di Francia” (1827); o al nostro Manzoni col “Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia” (1822). Si potrebbe osservare, inoltre, che le comunità nazionali sono indotte a ripensare la propria storia e a reinterpretare il proprio destino, tanto più in momenti di crisi o di trasformazione radicale. Si pensi, per limitarsi al caso italiano, alle narrazioni parallele e contrapposte della nostra storia nazionale nate all'indomani del consolidarsi del regime fascista: nella versione liberale di Benedetto Croce, in quella nazional-fascista di Gioacchino Volpe, o in quella marxista che si trova in nuce nei “Quaderni del carcere” di Gramsci. Ma anche alla funzione che ebbe, nei mesi di incubazione della Resistenza, “Pensiero e azione nel Risorgimento” di Luigi Salvatorelli, pubblicato nella primavera del 1943.
Il problema delle narrazioni nazionali sta al centro o sullo sfondo di diversi contributi recenti sulla storia e l'attualità del conflitto israelo-palestinese.
È posto in modo concreto e drammatico dal documentario Route 181. Frammenti di un viaggio in Palestina-Israele, pubblicato in DVD da Bollati Boringhieri (4 voll., 49 euro), di Eyal Sivan e Michel Khleifi, due registi, uno israeliano e uno palestinese, che percorrono Palestina e Israele con una telecamera sulla spalla, intervistando tutti quelli che incontrano sul loro cammino, moltiplicando così i punti di vista e le narrazioni sul conflitto mediorientale, le sue origini e prospettive, reinterpretate in un road-movie in presa diretta.
È messo a frutto nel prezioso manuale di storia, nato per le scuole israeliane e palestinesi, grazie al lavoro di un gruppo di insegnanti delle due parti, La storia dell'altro. Israeliani e palestinesi (cooperativa editrice Una città, 139 pp., 12 euro) [vedi più sotto], in cui la storia della regione è raccontata secondo due versioni, palestinese e israeliana, messe a confronto su due colonne — separate nell'edizione originale bilingue da una terza, bianca, in cui gli studenti possono scrivere la «loro» storia: che sia una versione originale o un tentativo di conciliazione delle due.
Ma un tentativo di scalzare le narrazioni tradizionali della storia del Medioriente, e in particolare la —a lungo prevalente, per quanto variamente articolata— storiografiasionista, è quello autorevole e originale di Ilan Pappe, docente di storia all'Università di Haifa e uno dei più impegnati e coraggiosi «nuovi storici» israeliani, nel suo recente A History of Modern Palestine. One Land, Two Peoples, pubblicato da Cambridge University Press (e in corso di traduzione in Italia da Einaudi). Come spiega provocatoriamente nell'introduzione al suo libro, Pappe intende «"bi-nazionalizzare" la storia e perfino "de-nazionalizzarla", per allentare la ferma presa del nazionalismo sulla storiografia»: cioè da un lato porre a confronto le due versioni nazionali della storia di Israele-Palestina, dall'altro rimettere in discussione o evitare gli schemi tipici delle storiografie nazionali: mitologici, etnocentrici, teleologici. Ma nel suo approccio, Pappe aspira anche a liberarsi dai preconcetti che provengono dalle teorie occidentali della modernizzazione, dall'elitismo della storia politica tradizionale, dalle definizioni e categorie a priori che i diversi gruppi nazionali, religiosi, etnici o clanici propongono o impongono nelle loro narrazioni contrapposte. Inoltre lo storico di Haifa ha scelto esplicitamente di adottare, anche sulla scia dei «subaltern studies» postcoloniali (ispirati in origine dal nostro Gramsci), un approccio soggettivo che assume innanzitutto il punto di vista palestinese, benché l'autore sia israeliano, che «ammette compassione per il colonizzato non il colonizzatore; simpatizza per l'occupato non l'occupante; sta dalla parte dei lavoratori non dei padroni». La narrazione storica di Pappe «spesso ma non sempre parteggia con gli sconfitti piuttosto che coi vincitori».
Il problema delle narrazioni nazionali parallele del conflitto mediorientale è, infine, esplicitamente tematizzato e teorizzato nel volume a cura dello stesso Pappe e del sociologo palestinese Jamil Hillal, Parlare con il nemico. Narrazioni palestinesi e israeliane a confronto (edizione italiana a cura di Maria Nadotti, Bollati Boringhieri, pp. 299, 24 euro
Si tratta di una raccolta di saggi di studiosi israeliani e palestinesi che cercano di ripensare alla storia di Israele-Palestina oltre le concezioni tradizionali e le visioni contrapposte, rimettendo anche qui in discussione le fonti utilizzate, le prospettive storiografiche e politiche convenzionali, e naturalmente rivedendo ciascuno i propri, congenitamente irreconciliabili, miti di fondazione. Sforzo comune, teorizzato dai curatori, è quello di costruire delle «narrazioni-ponte», cioè «il consapevole sforzo storiografico compiuto da storici appartenenti a società dilaniate da prolungati conflitti interni ed esterni per andare al di là delle narrazioni e storiografie in lotta tra loro». Esistono una serie di precondizioni che possono rendere possibile questo tipo di operazione storiografica. La prima, che ha dato il via in Israele a un vero e proprio movimento intellettuale, è quella che ha visto innanzitutto i cosiddetti «nuovi storici» israeliani, che Pappe definisce «post-sionisti», iniziare a riscrivere la storia del 1948, cioè della nascita dello stato d'Israele, oltre la leggenda e l'oleografia, riconoscendo —anche grazie all'utilizzo di documenti ufficiali divenuti finalmente consultabili— che essa segnò anche «l'espulsione di massa» di palestinesi, «con la conseguente distruzione di circa quattrocento villaggi e il massacro di alcune migliaia di palestinesi». Vi sono poi una serie di ridefinizioni della propria posizione di studio e osservazione, che riconoscano l'influenza «della propria politica identitaria sulla ricerca storica», con cui —citiamo sempre i curatori del volume— «la parte più forte ed egemone rinuncia al proprio potere di dominio sulla conoscenza, mentre la parte subalterna e più debole riduce il proprio ossequio nei confronti della propria ideologica narrazione storica». Vengono, infine, messi da parte la storia elitaria e nazionalista, e posti al centro della narrazione storica nuovi soggetti, in precedenza marginalizzati, come le donne, i lavoratori e i contadini, che costituivano tra l'altro una parte assolutamente preponderante della popolazione coinvolta da entrambe le parti.
I risultati di questi nuovi approcci segnano effettivamente l'avvio di nuove letture e interpretazioni della storia del Medioriente e dei conflitti che lo insanguinano da almeno oltre mezzo secolo, ma in realtà nel corso di tutto il Novecento — sebbene molta strada vi sia ancora da percorrere per affinare queste prospettive, moltiplicare i punti di osservazione, coordinarli e integrarli o almeno metterli in comunicazione, a costruire un nuovo quadro e nuove narrazioni, che continueranno a loro volta a trasformarsi nel tempo, com'è tipico di ogni storiografia viva e operante, tanto più attorno vicende così conflittuali e ancora irrisolte. Il ricorso alla storia orale, e in particolare al racconto delle donne, ad esempio, come nel saggio dell'antropologa palestinese Rema Hammami dedicato a Genere, Nakba e nazione, offre un'inedita, più ricca e drammatica visione della «catastrofe» palestinese (Nakba), cioè la nascita dello Stato ebraico coi conflitti che la precedettero, documentabili dal punto di vista palestinese soprattutto attraverso le memorie e i racconti personali, tipici o, meglio, addirittura irrinunciabili per la storia di una società all'epoca in maggioranza non ancora alfabetizzata. La riflessione dello storico palestinese Issam Nassar sull'«identità ambivalente» del Nazionalismo palestinese, mostra invece, d'altra parte, che la cronologia, l'evoluzione e la definizione stessa del nazionalismo palestinese non solo non siano scontate, ma siano particolarmente controverse e sfuggenti nella stessa storiografia araba e palestinese. Il movimento può essere infatti ricondotto nell'alveo più ampio del nazionalismo arabo o pan-arabo, come avveniva prevalentemente al discorso politico palestinese negli anni Sessanta; oppure datato alle prime espressioni politiche e giornalistiche che si riferiscano precisamente alla Palestina come entità politica distinta nei primi decenni del Novecento. La storia nazionale palestinese va del resto strettamente legata a quella di altre realtà a cui essa reagiva e con cui geneticamente interagiva: cioè quella ebraica, ma anche quella delle potenze mandatarie, e prima ancora dell'impero ottomano, o degli antichi o nascenti stati arabi. L'identità o le identità palestinesi, d'altra parte, in particolare al principio del Novecento, non erano prevalentemente di tipo nazionale, ma rispecchiavano piuttosto —secondo Nassar— «affiliazioni locali, regionali e religiose». E del resto la stessa identità ebraica o quella sionista, spesso supposte anche in questi contributi come monolitiche, vanno scisse e articolate nelle loro molte manifestazioni e nei loro diversi orientamenti, fedeltà, progetti, differenziati e talora antitetici, o persino contrapposti — esattamente come nelle attuali società israeliana e palestinese, che ancora oggi si confrontano e si scontrano anche al proprio interno.
Anche la parte israeliana di questo volume naturalmente ripensa e ridefinisce se stessa e i propri miti fondatori. Quelli del 1948 e della nascita dello Stato, che non furono soltanto una «guerra di indipendenza» come a lungo sono stati descritti in chiave risorgimentale; quelli della nascita e della vita di una democrazia, che è in effetti una «etnocrazia» o, nel migliore dei casi, una «democrazia etnica»; quelli che riguardano il trauma originario della Shoah, il suo spazio ed il suo «uso pubblico» nella politica e nella società israeliana. Quelli, infine, di una società sotto assedio, in cui una parte decide tragicamente di eliminare il proprio capo, infrangendo il tabu originario e ogni principio di convivenza civile, coll'uccisione del premier Yitzhak Rabin.
Un nuovo presupposto che dovrebbe riguardare entrambe le narrazioni, israeliana e palestinese, ed è proposto da uno specifico contributo dello stesso Ilan Pappe, è infine l'abbandono della propria «auto-vittimizzazione» e il riconoscimento di una «vittima» anche nell'«altro», e rispettivamente dell'esistenza di un «carnefice», che si tratti di se stessi o di altri. Per entrambe le parti è difficile riconoscere l'altra, o anche l'altra, come «comunità sofferente». D'altra parte, nota Pappe, «la negazione dell'altro, della sua sofferenza e delle sue sventure, è un elemento fondante per modellare le identità nazionali»; e nel caso di Israele e Palestina, «il controllo della memoria collettiva di entrambi i gruppi è parte della violenta lotta esistenziale per la sopravvivenza nazionale» — in una medesima terra, attorno ai medesimi simboli, aggiungiamo. Eppure, come spiegò lo storico francese Ernest Renan, nella sua celebre conferenza alla Sorbona del 1882, “Che cos'è una nazione?”: «l'essenza di una nazione sta nel fatto che tutti i suoi individui condividano un patrimonio comune, ma anche nel fatto che tutti abbiano dimenticato molte altre cose». E Renan sostenne anche, in quella occasione, che la nazione è il frutto di un «plebiscito quotidiano».
Non si può evidentemente pretendere che israeliani e palestinesi riconoscano plebiscitariamente l'esistenza di un'unica nazione: prospettiva irrealistica e ormai (o fin dall'inizio) antistorica; né che essi costruiscano il proprio futuro sull'oblio delle sofferenze inflitte reciprocamente o subite in passato da altri. D'altra parte pare anche evidente che la costruzione di nuove narrazioni parallele, incrociate, intrecciate, relativizzate e contestualizzate, non sia solo o affatto un'operazione accademica e intellettualistica, ma appaia sempre più come un requisito fondamentale, un'azione culturale e anche politica, o etico-politica, preliminare per guardare assieme con maggiore equilibrio e speranza, ma anche maggiore conoscenza di sé e dell'altro, al futuro della regione. Facendo quindi necessariamente passare il proprio futuro —com'è proprio di ogni nazione, e persino di ogni individuo— attraverso un ripensamento profondo, una nuova consapevolezza e interpretazione, e nuove narrazioni, della propria storia.