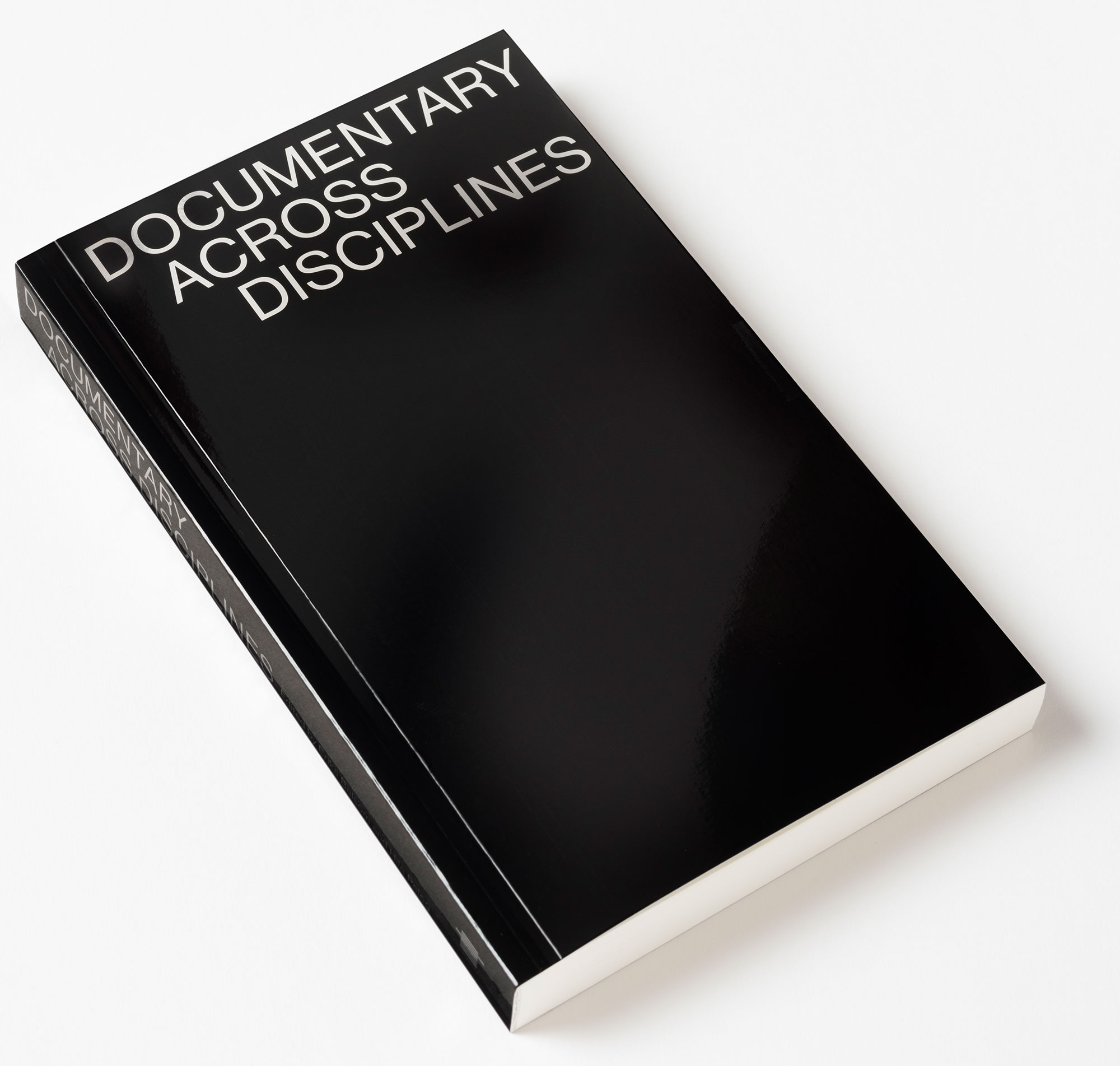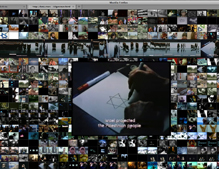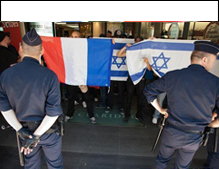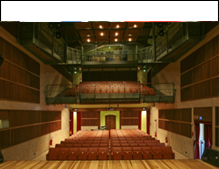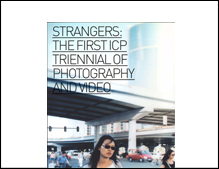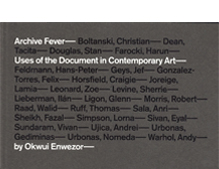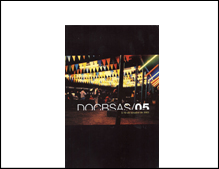-
Proposal for a visual media exhibition
with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -
Get my films
Buy DVDs online at www.momento-films.com -
IZKOR
slaves of memory
Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -
Common Archive Palestine 1948
web based cross-reference archive and production platform
www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -
Montage Interdit [forbidden editing]
With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -
Route 181
fragments of a journay in Palestine-Israel
Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST
-
The Specialist
portrait of a modern criminal
Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -
Jaffa
the orange's clockwork
Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST
-
Montage Interdit
www.montageinterdit.net
Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress
-
Common State
potential conversation [1]
Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -
Towards a common archive
testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine
Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013
-
I Love You All
Aus Liebe Zum Volk
Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST
Quartiere Gambetta, un passo o appena più da Pere Lachaise, da dove tanti anni fa i rivoluzionari della Comune di Parigi hanno combattuto e sono stati sconfitti. È qui, in un portoncino quasi invisibile che ha la sua sede la Momento film di Eyal Sivan. E è anche qui che lo incontriamo, una mattina quasi d’autunno parigina. Dentro c’è il caos, scatole di cartone ovunque. Sorride, prepara un caffè arrotolando una cartina, la prima di una serie infinita di sigarette. Un uomo va avanti e dietro coi pacchi, gentile, parla inglese, faceva il fotografo - dice Sivan - poi si è stufato e adesso organizza traslochi... Sivan sta andando via, si trasferisce a Londra lasciando per ora – “per sempre” con uno come lui è un’espressione che non funziona – Parigi, dove era arrivato da Israele alla fine degli anni Ottanta. Una vita. O quasi almeno per chi è nato nel 1964, la città era Haifa, la storia della famiglia la scropriremo nella nostra lunga conversazione.
La stanza di Sivan è quasi vuota. Non c’è più la fotografia di Hannah Arendt, l’incontro intellettuale che più ha segnato la sua poetica, la sua esigenza di provocare verità. Non ci sono i manifesti, i libri, tantissimi visto il numero di scatole. Restano le immagini dei santi appese alla parete, e una incredibile collezione di “palle di neve” chiusa in una vecchia vetrinetta.
“Da cosa cominciamo” ci chiede. Già da cosa. A Londra insegnerà al college, c’è la tesi di dottorato da finire. Tema: la rappresentazione della vittima al cinema. Più o meno. Ovvero la ricerca di tutti i suoi film, con l’evidenza asciutta di Uno specialista.
Difficile andare via, organizzare tutto ma la Francia si capisce che gli da dolore, e rabbia, è come restare nella stessa casa dove si è vissuto un grande amore finito male. La Francia, il paese del sogno di ragazzo boehemienne, che solo qualche anno fa lo ha massacrato con la storia di Route 181. Lettere, petizioni, accuse violentissime fino alla censura e al divieto di proiettarlo al festival del Cinema du reel, se non una sola volta e con un apparato di sorveglianza ai limiti del ridicolo. Contro di lui ci sono tipi come Alain Finkelkraut, Henry Levy, Claude Lanzmann. Non ci sarebbe da disperarsi se non fosse che quella lettera l’hanno firmata registi, scrittori, tutte persone che per principio dovrebbero schierarsi contro ogni forma di censura. A difenderlo certo c’erano Godard, Todorov, Balibar, Comolli ... Le lettere però erano solo una piccolissima parte di una trama sempre più aggressiva e difficile da sopportare.
Non è una persona “facile” Eyal Sivan. Perché è chiaro, diretto, coerente col suo pensiero. Tutte cose che oggi spaventano, mettono a disagio, addirittura disturbano. Non si nasconde nel compromesso, pure se piccolo o ambiguamente mascherato da saggezza. Sin dal primo film, Aqabat Jaber-Vie de passage che precede di qualche mese la prima Intifada, e racconta la vita dei profughi palestinesi. Una provvisorie, sospesa nel nulla. Poi Izkor, Uno specialista, Pour amour du peuple, per citarne solo qualcuno. La costruzione di Israele sulla Shoah, il nazismo nelle sue pieghe invisibili, la Germania del socialismo reale. Sì, ci vuole molto coraggio e moltissima consapevolezza per tutto questo. Ma il cinema di Sivan, e la riflessione, o, come dice lui, il suo “dispositivo” non mentono né camuffano, dicono subito cosa stanno mettendo in campo. Quale è la ricerca e quale è la provocazione. Che riguardano la consapevolezza dello spettatore e la natura stessa dell’immagine, la possibilità di rappresentare, di tradurre in visualità capovolgendo sicurezze e miti fondatori. La Storia nel suo divenire presente, ovunque ci si trovi, in Israele o nella Germania est, negli Stati Uniti, in un campo profughi o nell’aula di tribunale davanti a un criminale nazista, uomo assolutamente comune, dunque disturbante.
Sivan non si ferma mai. È apolide nel DNA, e non soltanto perché è nato in una famiglia di emigrazione ebraica esteuropea in America latina prima di approdare in Israele. È uno stato mentale più che geografico, dove si intrecciano la lotta politica, il cinema, gli spostamenti, da Gerusalemme a Tel Aviv, poi Parigi, ora Londra. Ma, ci dice, parla cinque lingue: ebraico, spagnolo, che era la lingua di famiglia, dei genitori arrivati in Israele dall’Uruguay, inglese, francese, arabo perché era importante conoscerlo, e a partire dalla quinta non si fa più nessuno sforzo per imparare. Lo stesso movimento del suo fare cinema, pur restando dentro a una prospettiva molto netta, messa però alla prova ogni volta in situazioni diverse.
“Da cosa cominciamo allora” ci dice ancora. “Chiedete e io rispondo”.
Iniziamo dalla tua storia familiare. Quali sono le vostre origini?
La mia è una famiglia di emigranti, i miei nonni materni venivano entrambi dall’est, dalla Polonia, la zona del paese che oggi è l’Ucraina e che chiamano la Galizia orientale polacca. La famiglia di mio padre era in parte russa e in parte della Transilvania... Si sono incontrati tutti quanti in America latina, in Uruguay, o almeno questo vuole la nostra mitologia familiare … che, come tutte, racconta tante belle storie, in parte menzogne e in parte mezze verità. Mia nonna materna è sbarcata in America latina agli inizi degli anni Trenta, ma non è stata la guerra a portarcela quanto piuttosto la crisi economica catastrofica che la Polonia attraversava in quel momento e il forte antisemitismo. Problemi economici e antisemitismo vanno sempre insieme! Mio nonno è partito con alcuni amici, volevano andare in America ma il biglietto costava troppo e così si sono ritrovati a Montevideo invece che a Ellis Island. I miei genitori sono nati in Uruguay, sono uruguagi ebrei. Entrambe le famiglie non erano particolarmente praticanti, la famiglia di mia madre aveva una maggiore coscienza ebraica, onorava le feste... Quella di mio padre era invece atea. I miei si sono conosciuti all’inizio degli anni Sessanta e hanno deciso quasi subito di lasciare l’Uruguay. Era il momento di esplosione della sinistra in Sudamerica ma soprattutto era il periodo in cui in Uruguay cominciava a farsi sentire la cosiddetta “influenza della Cia” sull’America latina. Non c’erano ancora i tupamaros ma l’Uruguay per primo sperimentava la grande manovra americana, la costruzione cioè di un’alleanza con l’estrema destra che porta alla dittatura militare. Mia madre aveva fatto studi classici, storia dell’arte in particolare, e aveva vissuto un periodo a Parigi. Mio padre frequentava la facoltà di architettura, che è molto importante nella storia della sinistra in Uruguay: è da lì che viene Raul Sendic, il leader dei tupamaros. Lui però non era un militante di sinistra; mia madre era più impegnata, era una sionista di sinistra. Il sionismo di sinistra ha sempre avuto rapporti problematici con l’estrema sinistra dell’epoca specialmente dopo la conferenza dei Tre Continenti a Cuba. Castro infatti aveva invitato tutti i movimenti della sinistra nel mondo tranne la sinistra sionista. Gli ebrei dei diversi gruppi di sinistra ci sono rimasti molto male. Penso però che mio padre e mia madre abbiano abbandonato l’Uruguay più per ragioni personali. Erano giovani, non trovavano il posto molto stimolante, cercavano qualcosa di diverso...
E come mai hanno deciso per Israele?
Qui siamo davvero in piena mitologia familiare. Raccontano che al momento di scegliere volevano un paese nuovo ma che avesse una storia classica. Anche per i loro studi, mia madre aveva nel frattempo deciso di dedicarsi all’archelogia. È interessante il loro rapporto, uno costruiva, l’altra cercava le rovine... Sarà per questo che poi hanno divorziato. Avevano preso in considerazione tre possibilità. Una era l’Algeria, che aveva appena conquistato l’indipendenza, era quindi un paese nuovo ma con un passato classico. Un’altra era Cuba, la grande speranza della gioventù in America latina, dove però mancava la storia classica. La terza era Israele, quella che hanno preferito. Sono arrivati nel ‘63, io sono nato un anno dopo. All’inizio abitavamo nel nord del paese, mio padre continuava i suoi studi di architetto, mia madre lavorava come guida turistica per il ministero degli affari esteri, la punta della propaganda. Poi ci siamo trasferiti a Gerusalemme, era il ‘68 o il ‘69… Mio padre è entrato alla Scuola di Belle Arti dove insegnava architettura, mia madre venne ammessa all’università, alla facoltà di archeologia. Ecco, questo è un po’ il quadro familiare nel quale sono cresciuto. I miei nonni materni ci hanno raggiunto qualche tempo dopo, quelli paterni sono rimasti in Uruguay e sono morti lì.
Per la mia formazione è importante che i miei genitori siano dei sionisti di sinistra. È un concetto sempre un po’ complicato da spiegare, è come dire un quadrato tondo, è una contraddizione in termini. Nonostante questo, erano molto distanti dal nazionalismo israeliano. Basta pensare che hanno preso la nazionalità israeliana solo vent’anni dopo il loro arrivo in Israele. Avevano la carta d’identità, perché in Israele si può avere uno statuto di residente permanente e di cittadino straniero. Loro hanno detto ‘beh, la cittadinanza non è mica un paio di calzini che si prende così ... “. Per anni sono rimasti stranieri anche se sul piano culturale. La loro, insieme a quella americana, era l’immigrazione privilegiata. I sudamericani erano avvolti in una specie di aura romantica, non c’era alcuna ostilità nei loro confronti, anzi. Esisteva un grande interesse verso la musica e in genere la cultura dell’America latina. Il solo segno che li distingueva era un accento molto forte che non rappresentava certo un problema. Eppure negli anni sono diventati profondamente israeliani, si sono integrati totalmente. Non era tanto la cultura israeliana a interessarli; anzi, con quel tipico snobismo latinoamericano, consideravano gli israeliani un po’ rozzi, non particolarmente colti. Però volevano che i loro figli fossero israeliani. Perché? Non volevano che fossimo ebrei. Può sembrare assurdo ma è un punto estremamente importante, e non conta se è vero o no e in quale parte della mitologia familiare rientra. I miei genitori erano convinti che essere ebrei in giro per il mondo comportasse un’inevitabile dualità – si è ebrei-italiani, ebrei-francesi e cosi via... – e non volevano questo per noi. Noi dovevamo essere interamente israeliani. Del resto il fondamento principale del sionismo è cancellare l’ebraismo nell’identità nazionale. Nell’immagine fabbricata dai sionisti l’ebreo è una persona debole, un perseguitato, un pauroso, che pensa solo ai commerci, che non sta mai a casa... Il sionismo sotto molti aspetti è vicino all’antisemitismo.
Puoi spiegare meglio questo punto?
Il sionismo ha inventato un popolo, chiamandolo popolo ebraico, contro l’ebraismo. Prima c’era il popolo ebraico, o popolo di Israele, che però non esprimeva un’idea di popolo in senso giuridico. Il sionismo ha utilizzato in qualche modo la definizione di popolo data da Mussolini, ovvero un gruppo di persone che combatte insieme. L’invenzione di un popolo, che non è comunque una specificità del sionismo, per un certo periodo va contro la realtà ebraica, la storia ebraica, e soprattutto contro l’ebraismo. I sionisti consideravano gli ebrei dei deboli, li definivano con disprezzo “orientali”. Il cuore del sionismo è l’Europa dell’est ma quando Theodor Herzl, il fondatore del sionismo, parla degli yiddish li descrive come dei primitivi, dei barbari, gente piena di superstizioni, dei “barbuti” con lo stesso tono che oggi l’occidente riserva all’Islam. Per i sionisti gli yiddish incarnano “l’orientale”, pur essendo europei dell’est. In occidente allora non esisteva la figura dell’ebreo orientale come arabo.
Oggi posso dire che mi interessa la riflessione binazionale in Israele e al tempo stesso definirmi un antinazionalista. Però sono consapevole che esiste una realtà nazionale, che il sionismo è riuscito a creare “l’israelitudine” e gli israeliani. Nel bene e nel male. Abbiamo una lingua e una cultura che non sono quelle ebraiche anche se si continua a strumentalizzare politicamente l’ebraismo. All’interno di questa realtà nazionale ci sono delle differenze tra idea di nazione, coscienza nazionale e nazionalismo. Lo stesso Eichmann in Uno specialista dice che il nazionalismo è il principale responsabile di tutti i mali perché genera egoismo. Ai nostri giorni si tende a considerare la questione nazionale superata, c’è internet, ci sono le multinazionali, non ci sono frontiere. Ma non è vero. La questione nazionale esiste ancora, c’è una coscienza nazionale palestinese chiara come ce ne è una israeliana, una italiana, una francese e così via. Per un italiano è più facile rappresentarsi come tale che come europeo. Il punto è lo stato-nazione. La struttura che oggi esprime questo concetto per eccellenza è proprio Israele perché è lo stato di una nazione immaginaria.
E questo è il principale risultato del sionismo che ha cancellato la cultura della diaspora.
La dualità che sta nella consapevolezza di essere ebrei e nel sentimento di appartenenza nazionale, di essere parte cioè di un gruppo sociale che non è solo una religione, è una ricchezza che caratterizza l’esilio. Bisognava saperla accettare, mentre il sionismo è riuscito a cancellarla, al punto che ormai questa dualità, complessa e interessante, sopravvive solo al di fuori di Israele. I francesi ebrei sono diventati degli ebrei francesi, gli italiani sono ebrei italiani e via dicendo.
Come era Israele quando ci arrivarono i tuoi genitori?
La presenza degli arabi era stata eliminata. Fino al 1967 c’era un controllo militare in Galilea, la maggior parte degli arabi del ‘48 era stata espulsa. Israele era un paese ebraico con una forte egemonia degli askenaziti, gli ebrei europei. Gli ebrei orientali, maghrebini ecc, arrivati negli anni Cinquanta, venivano confinati nelle bidonville o nelle città satellite. I miei genitori sono askenaziti e godono dunque di ogni privilegio. Vivono in un paese nuovo, bianco, dove c’è il sole dell’oriente ma senza l’oriente. Un sogno. Almeno fino al 67, quando scoppiaì la guerra dei sei giorni.
Possiamo dire che è stato il primo shock per il paese?
Non credo che sia stato uno shock, almeno per i miei genitori. Mio padre si è arruolato nell’esercito ma senza combattere. I miei incarnavano la generazione vittoriosa di un paese in cui prevaleva l’immagine dell’israeliano forte, che poteva viaggiare ovunque, visitare Gerusalemme, Betlemme, andare nei bazar, comperare ciò che voleva. Erano gli anni della belle epoque coloniale. Gli arabi, i palestinesi, stavano lì intimiditi, spaventati, mentre gli israeliani erano gli splendidi viaggiatori che scoprivano il territorio. E cominciava il boom dell’edilizia e dell’immigrazione.
Credo che il vero trauma, per i miei genitori come per tutti, sia stato il 73, la guerra del Kippur.
Nel 67 loro erano giovani, avevano ventisette anni, si sentivano immersi nel sentimento dominante di trionfalismo. È vero che si era diffusa una grande paura prima del 67, ma era stata costruita soprattutto dalla propaganda. Oggi il nuovo corso della storiografia israeliana scrive le cose in modo diverso però è stato proprio quello il momento, tra il 66 e il 67, in cui si comincia a parlare dei cosiddetti “confini di Auschwitz”, alle Nazioni unite i politici israeliani dicevano che Israele corrispondeva soltanto ai vulnerabili confini di Auschwitz... Ora sappiamo bene che è stato Israele a cominciare la guerra del 67 - gli arabi non la volevano - perché era sicuro di vincerla, come poi è stato. La simbologia che ne è risultata era molto forte: il piccolo israeliano che combatte riuscendo a resistere e a difendere il suo paese.
Ma l’aspetto interessante di questo periodo è un altro. Gli anni tra il 1948 e il 1967 sono visti dagli israeliani come un periodo “democratico”. È la ragione per cui si dice ancora oggi che bisogna tornare ai confini del 67.
Noi sappiamo però che la verità storica è un’altra: dal 48 al 66 in Galilea a controllare gli arabi c’è un vero e proprio regime militare. Alla fine di questo periodo passano nove mesi prima che Israele proceda a una nuova occupazione in Cisgiordania (con Gerusalemme est, le alture del Golan, la Striscia di Gaza quello che poi diventano i Territori occupati, ndr). La verità è che abbiamo vissuto solo nove mesi senza mettere in atto l’occupazione: siamo stati uno “Stato ebreo democratico” per nove mesi.
Tel Aviv non era ancora la metropoli moderna di oggi...
No, anche se è stata sempre una città metropolitana. Ma quelli erano gli anni d’oro di Gerusalemme. La Scuola delle Belle arti era molto importante e così l’università. In più l’esotismo era a portata di mano, visto che gli arabi vivevano accanto.
Poi cosa è accaduto?
La mia famiglia apparteneva al ceto intellettuale, a quello che in Israele viene definito l’ambiente accademico. Abitavamo in un quartiere totalmente bianco e askenazita dove i miei genitori avevano comprato una casa quando era ancora in costruzione. Era un quartiere nuovo, chiamato French Hill, cresciuto sui territori occupati dopo il 67. Ci eravamo trasferiti lì qualche mese prima della guerra del 73, l’evento che, come dicevamo, è stato una sorpresa assoluta. È scoppiata all’improvviso e da subito la gente l’ha vissuta come una prova estremamente difficile. Tutti gli uomini sono stati mobilitati e anche mio padre è rimasto lontano a lungo come riservista… Alla fine della guerra c’è stata una grande manifestazione, era la prima volta che accadeva nel paese e è stata anche la mia prima manifestazione, avevo sette anni. I miei genitori continuavano a lavorare anche per l’ambasciata dell’Uruguay. Mia madre faceva delle traduzioni, non so quale fosse esattamente l’attività di mio padre. Penso che fosse grazie a mio nonno che era ambasciatore del governo uruguagio. Noi potevamo fare acquisti nei negozi riservati ai diplomatici, un lusso enorme in un paese come Israele dove negli anni sessanta e settanta non si trovavano grandi cose... Viaggiavamo pure molto all’estero, fatto anch’esso piuttosto fuori dal comune.
Stavi raccontando della tua prima manifestazione dopo la guerra del Kippur. Contro cosa si protestava?
Un movimento molto numeroso reclamava una commissione di inchiesta parlamentare per indagare sulla guerra, sul perché ci siamo fatti trovare impreparati… Poteva sembrare una manifestazione di sinistra, ma in realtà esprimeva uno spirito patriottico di centro. Comunque è stata una grande manifestazione contro il governo Golda Meir. Era interessante anche perché rivelava una convinzione degli israeliani. Lo slogan era “lo stato siamo io e te” e quindi voi politici avete il dovere di rendere conto a me cittadino perché io sono lo stato. È stata un’esperienza che mi ha segnato.
In che senso?
Non so spiegarlo con precisione... Ne conservo un ricordo molto chiaro, soprattutto della consapevolezza che manifestare è fondamentale nella vita di un cittadino. Forse perché ci sono andato coi miei genitori, o perché era considerata una manifestazione dell’opposizione, credo la prima grande manifestazione dell’opposizione israeliana sionista.
Distingui sempre tra “sionista” e “sionista di sinistra”. C’è una differenza se non un conflitto tra queste due posizioni?
Il quadro politico determinato dal sionismo che sancisce uno stato ebraico per gli ebrei è molto importante nella mia formazione e in tutto il mio lavoro. Possiamo discutere di cosa sia lo stato ebraico e di che cosa voglia dire essere ebreo, ma dentro il sionismo la rivendicazione di partenza è quella di uno stato ebraico che appartiene agli ebrei. Le diverse correnti nel movimento sionista rimandano sempre a questo principio. Senza fare paragoni troppo diretti è un po’ come nel grande movimento socialista, dove a destra c’è la socialdemocrazia e a sinistra i maoisti, i trotzskisti, i brigatisti... Il quadro di riferimento però è sempre il socialismo. Lo stesso vale per il sionismo. Il sionismo di sinistra ha posizioni completamente differenti da quello di destra su molti piani, ma nessuno dei due può fare a meno della rivendicazione di uno stato ebraico. Ciò di cui si discute è la sua forma, tutti però concordano sulla sua esistenza.
Sì, ma dire uno stato ebraico per gli ebrei pone subito enormi questioni.
Il sionismo è pieno di contraddizioni, su questo siamo d’accordo, ma che si manifestano sempre al suo interno. Quando parlo di “opposizione” lo dico riferendomi al quadro sionista. I miei genitori si sono percepiti per anni come parte di questa opposizione, anzi ancora oggi mia madre si considera dell’estrema sinistra sionista perché esprime le posizioni più radicali. Ma dentro il sionismo, non fuori da esso, È una cosa complessa.
Resta il fatto che se parli di uno stato ebraico la conseguenza immediata è che devi essere ebreo per farne parte. Si può diventare socialisti, maoisti, ecc. ma nessuno può diventare ebreo.
Per questo ho detto che non voglio fare paragoni, era solo un esempio. Non ci sono molte cose paragonabili al sionismo. Il colonialismo sionista, per fare un altro esempio, è una forma particolare di pratica coloniale, almeno perché è un colonialismo senza metropoli. Il dato singolare è che nella storia politica dei sionisti convivono sempre due parti in opposizione, d’accordo però su una cosa, lo stato ebraico. Esiste un paradosso ancora più complicato che è lo “stato ebraico democratico”. Come è possibile? Se è uno stato ebraico per gli ebrei come può essere democratico visto che la democrazia riguarda tutti? È un paradosso a volte perverso. Ma non finisce qui. I sionisti di sinistra sul piano economico hanno idee da liberali di destra. Il termine “sinistra” riguarda quindi solo la relazione coi palestinesi, la questione dei territori occupati. Il movimento più a sinistra del sionismo nelle politiche economiche appoggia le privatizzazioni, non esprime per niente una politica di sinistra. Però è considerato tale perché spinge alla restituizione dei territori, appoggiando la nascita di uno stato palestinese. La nozione destra-sinistra non vuol dire nulla dentro al sionismo, il fatto è si è sionisti oppure no. E come quando una donna è incinta, non è un po’ incinta o lo è o nonlo è.
Torniamo alla tua storia. Eravamo rimasti al 1973, alla guerra del Kippur e allo scontento che pervade il paese.
Dopo il 73 appare un nuovo grande partito di centrosinistra, il Movimento democratico per il cambiamento. Un partito askenazita, bianco, con un’importante militanza laica, che sosteneva il compromesso con i palestinesi. Il leader era Yadin, un vecchio capo dell’esercito israeliano, un criminale della guerra del 48 che era anche l’archeologo israeliano più famoso, a capo del dipartimento di archeologia. Era il professore di mia madre che non a caso è entrata nel partito. Il 77 è l’anno delle elezioni, una data chiave nella storia della mia famiglia e del paese. I miei genitori hanno divorziato e per la prima volta nella storia di Israele il partito laburista viene sconfitto. Al potere arriva Begin col Likud. La sinistra sionista askenazita era sconvolta, la definirono una vittoria della guerra, del fascismo ma in queste critiche c’era anche una buona componente razzista. Begin era stato votato dalle grandi masse del paese che sono ancora oggi prevalentemente gli ebrei arabi.
Io intanto avevo iniziato a interessarmi alla politica, sono arrivato al Movimento democratico per il cambiamento grazie al coinvolgimento dei miei genitori. Il 77 è stato anche l’anno di Camp David e della nascita di Peace now! che forse non tutti ricordano è cominciato con una lettera di alcuni ufficiali dell’esercito. Li chiamavano i pacifisti israeliani ma erano militari, askenaziti bianchi, occidentali... Quando Begin è partito per Camp David dove c’era Sadat, l’idea di tutti i grandi movimenti di contestazione era appoggiare il compromesso. In particolare Peace now!, un nome quasi messianico. Ero molto coinvolto in Peace now!, finché accadde che mi arrestarono perché insieme a dei compagni avevo appeso degli striscioni all’entrata di Gerusalemme, vicino alla casa di Begin, durante una manifestazione. Peace now! rifiutò di difenderci. La cosa ci sembrò ridicola, e quindi abbiamo fondato a Gerusalemme un movimento che si chiamava Liceali contro l’integralismo religioso. All’epoca ero ancora antireligioso e ultra laico, con gli anni ho capito quanto fosse assurdo... Avrò avuto quattordici o quindici anni, rivendicavamo il diritto di tenere aperte le sale cinematografiche a Gerusalemme il venerdì. Perché si doveva chiudere tutto, perché tutto doveva essere religione? Ci sembrava medioevo... Insomma i discorsi che circolano in Europa oggi noi li facevamo già nel 77/78. Ci hanno arrestati ma visto che eravamo ragazzi di buona famiglia la cosa si è risolta subito. Mia madre ha sistemato le cose. È sempre così coi figli della borghesia… Questa esperienza più la militanza in Peace now! hanno contribuito a radicalizzarmi.
In che senso dici parli di assurdità dell’ultralaicismo? È cambiato nel tempo il tuo rapporto con la religione?
È cambiato piuttosto il mio rapporto con la laicità usata come arma contro la religione. Tempo fa ho scritto un articolo su un giornale israeliano in cui mi schieravo contro la scelta di fare il Gay Pride a Gerusalemme. Le mie non sono ragioni religiose: non posso sentire parlare di tolleranza in una città dove si pratica una discriminazione continua nei confronti degli arabi. In casi del genere il discorso laico è soltanto opportunismo, o scelta di convenienza. Un po’ come nel dibattito sul velo, dove la laicità che decide di negarlo si trasforma in uno strumento di oppressione, senza però interrogarsi sulle opportunità, sui singoli casi, su cosa significa. Non voglio adesso dire che sono per il velo ma di fronte alla realtà del mondo contemporaneo credo che sia necessario rivedere il concetto di laicità. Senza parlare poi delle ipocrisie che lo circondano, e delle ambiguità. L’Europa e l’America sono in Afghanistan a combattere perché le donne si liberino dal burqa. Il fatto che tutte lo portino ancora, con ancora maggiore accanimento, non viene preso in considerazione così come non vengono mai presi in considerazione gli eventi che hanno condotto a una certa realtà, chi ne è responsabile, cosa potrebbe davvero servire. Ancora un altro esempio: si parla moltissimo dell’Iran, e il punto centrale sono sempre le donne, che forniscono l’alibi per una nuova guerra. Nessuno però dice mai nulla sull’Arabia saudita, un regime spaventoso, che non ha mai fatto un gesto quando gli iraniani hanno combattuto per liberarsi dallo Scià. Tornando a Israele, penso che il problema anche qui non sia la religione in sé. La questione sta nella definizione stessa di stato ebraico e nel suo rapporto con la democrazia. In teoria si tratterebbe di uno stato laico ma chi decreta la chiusura dei negozi o dei cinema il venerdì sono i deputati al parlamento non i religiosi… Chi tiene in ostaggio la religione è la laicità, a partire dalla fondazione di Israele dove il sionismo ha voluto uno stato ebraico in opposizione all’ebraismo che non aveva caratterisiche nazionaliste.
Andiamo un momento indietro. Quale era l’atmosfera culturale che si respirava a casa tua? E come era invece la tua scuola elementare, che genere di rapporti avevi con gli insegnanti, come vivevi la propaganda che doveva essere la stessa che racconti in Izkor. Gli schiavi della memoria?
A casa siamo cresciuti in una situazione che non so quanto allora poteva essere strana. I nostri genitori non erano in grado di aiutarci nei compiti, a parte matematica, perché non parlavano abbastanza bene l’ebraico. A casa prevaleva la cultura latinoamericana. Tra noi si parlava spagnolo, ascoltavamo musica classica europea o sudamericana, mentre le nostre letture erano soprattutto francofone. Mia madre quando studiava a Parigi negli anni 60, si sedeva al caffé Select per tenere d’occhio la Coupole sperando così di vedere Sartre e Simone de Beauvoir. Sono cresciuto nel mito di Sartre, ho letto i suoi libri a dodici o tredici anni senza capire nulla... C’erano cose davvero bizzarre nella nostra educazione, leggevamo i Diari di Che Guevara perché era il libro dell’adolescenza di mia madre ma avevamo anche molti libri di Storia con la “S” maiuscola, mitologia greca, storia della Roma antica, che erano stati gli studi di mia madre, letteratura greca e romana... I classici erano accanto alla letteratura sudamericana contemporanea, Garcia Marquez, un’altra passione giovanile dei miei. C’erano giornate in cui tutti insieme sfogliavamo le grandi enciclopedie. Allora non avevamo la televisione che era considerata negativa. Così come era vietata la Coca-Cola: Non poteva neppure entrare in casa, era come portare la Cia in salotto. Tutto cose che facevano parte del retaggio di sinistra dei miei... Lo stile di vita a casa non aveva nulla in comune con quello che prevaleva all’esterno. Negli anni Settanta l’educazione scolastica era nel suo momento più ideologico, a parte forse gli anni Cinquanta. Anche se la scuola era laica, si studiava molto la Bibbia. Cosa significava? Che la Bibbia diventava la storia. Studiavamo storia sulla Bibbia ma non come fosse un insegnamento religioso, anzi. Nella separazione tra casa e scuola avevo il vantaggio di provenire da un ambiente privilegiato, quindi cercavo di essere il migliore nell’apprendimento della cultura israeliana. Alla materna ero già bravissimo nello studio della Bibbia e negli studi della patria, la geografia, i nomi dei nostri fiumi, delle diverse zone del paese... Poi c’era la geografia delle Terre di Israele e i più grandi cominciavamo a studiare la storia del popolo ebraico.
Tutto il sistema dell’istruzione in Israele si fonda su una contrapposizione: noi e gli altri. La storia del mondo e la storia degli ebrei, la geografia del mondo e quella dello stato di Israele… Ero bravo in tutto tranne che in matematica, un incubo ancora adesso. Negli anni Settanta c’è stata la grande riforma scolastica. Il ministro dell’educazione veniva dal partito nazionalista, religioso di destra, e a posteriori penso che sia stato un bravo ministro. Nei nuovi programmi c’era un libro che si chiamava Eredità delle comunità ebraiche orientali. Fino a allora nei libri di storia israeliani gli ebrei orientali non esistevano, studiavamo Storia del popolo ebraico che raccontava soltanto degli ebrei d’occidente. Eredità delle comunità orientali mescolava folklore, etnologia e aneddoti sulla sofferenza degli ebrei orientali sotto l’Islam. Era una collezione di bugie assolute.
Ma i libri di storia in Israele erano “sovietici”, come era “sovietico” il paese in cui sono cresciuto. Si insegnavano soltanto falsità assai patriottiche, una caratteristica del sionismo. Ci facevano fare un sacco di gite, marciavamo in lungo e largo per conoscere il paese, la natura, i duemila anni di Storia ebraica, dove ogni luogo aveva una sua evidenza, qui è accaduto questo, qui quest’altro... La nostra era una scuola in cui di fronte alle rovine di un villaggio palestinese ci veniva detto che risalivano all’epoca delle crociate.
È un tipo di propaganda comune a tutti i paesi che vogliono rappresentarsi come verità assolute.
Esattamente. In quel periodo Israele si vedeva come un paese socialista, conservando del socialismo solo le strutture, la tattica e i programmi scolastici molto rigidi. E una forma di distillazione continua dell’ideologia sionista. Ho trovato una mia vecchia fotografia, avrò avuto dodici anni, che a guardarla oggi c’è da morire dal ridere. Sto lì, deve essere mattina presto, pronto a partire per una qualche escursione in pantaloncini corti, lo zaino, il cappello storico israeliano che chiamiamo il “cappello da idiota”, e l’aria molto fiera perché in mano tengo la cartina del paese con su scritto “Terre di Israele”. Un altro aspetto della propaganda erano le cerimonie, ne avevamo tantissime. In quei giorni speciali ci dovevamo vestire di blu e bianco, i colori della bandiera, come il primo giorno di scuola. Eravamo noi stessi la bandiera. E dire che la mia era una scuola liberale, di sinistra, assolutamente laica ma molto sionista. Ho frequentato la materna, le elementari, le medie poi sono passato al liceo René Cassin, dal nome del redattore della dichiarazione dei diritti dell’uomo, dove poi ho girato Izkor. Era una scuola dell’Alliance française. Mi hanno espulso prima della fine dell’anno perché avevo organizzato uno sciopero contro l’obbligo di indossare la divisa. Ero quel che si dice un “ragazzo problematico”, oggi direbbero iperattivo... La mia fortuna era avere alle spalle una famiglia askenazita e intellettuale: un ragazzo problematico diventava così un ragazzo molto dotato. Se fossi stato ebreo orientale sarei finito in una scuola professionale.
Vi racconto un episodio abbastanza importante. Ci avevano invitati a una trasmissione della televisione in cui i ragazzini facevano i reporter. Ero stato selezionato, e questo ha fatto scattare il mio interesse per le immagini, per la televisione. Dopo l’espulsione dal René Cassin i miei hanno cercato una scuola adatta a me ma avevo problemi un po’ ovunque. A quel punto la sola soluzione era la scuola sperimentale dove si praticava un’educazione aperta, autogestita, dove ciascuno sceglieva gli indirizzi che preferiva, senza obblighi d’orario, e tutti stavano seduti in cerchio e davano del tu ai professori. La scuola però non mi interessava, contava solo l’impegno sociale e politico a cui dedicavo tutto il mio tempo. In quel periodo ho cominciato per la prima volta a frequentare dei palestinesi. Abitavamo nella zona nord est di Gerusalemme, di fronte c’era un villaggio palestinese dove avevo degli amici. Non era ancora una dichiarazione politica, ma piuttosto un’avventura che però ha comunque determinato le scelte successive. Potrei fare una mitologia del mio rapporto con la politica, dire che avevo una coscienza politica già a quindici anni, che ho partecipato a grandi manifestazioni molto violente, che sono entrato nei gruppi di attivismo sociale che erano movimenti di ebrei orientali dei quartieri poveri di Gerusalemme. Fino al movimento di estrema sinistra della gioventù antisionista… Ma questa rappresentazione di me sarebbe vera solo in parte. È chiaro che se non avessi avuto una passione per la politica non lo avrei fatto, al tempo stesso era un modo per dichiarare una diversità. I ragazzi a quindici anni cominciavano già a pensare all’esercito, c’è chi voleva essere pilota, chi paracadutista… Non volevo essere come tutti gli altri, l’estrema sinistra era perfetta per ottenere il mio scopo. Inoltre nei quartieri “difficili” di Gerusalemme si trovava più facilmente l’hashish. E se per fumarmi una canna dovevo fare una scelta politica ero disposto a farlo. Dico così per non mettere le cose unicamente su un piano politico. Ma frequentare quelle persone mi ha permesso pian piano di conoscere la situazione degli ebrei orientali, ho visto cosa significava, la discriminazione che subivano. Improvvisamente a quindici anni ero diventato un bianco, una cosa di cui prima non avevo alcuna consapevolezza. Come non pensavo di essere un askenazita. Siamo gli unici a non considerare noi stessi come tali. Nell’estrema sinistra c’erano anche cose che mi piacevano molto. La lettera dei 21, un gruppo di liceali, appena più grandi di me, che rifiutavano di andare nei Territori occupati, è stato un evento straordinario. Erano di Tel Aviv e a Gerusalemme avevo organizzato un’iniziativa in loro sostegno. Ricordo bene che sono andato alla manifestazione di Peace now! e davanti al parlamento israeliano ho distribuito dei volantini che avevo fatto da solo, con la fotocopiatrice della scuola, in cui prendevo posizione a favore della disobbedienza nei Territori occupati. Quelli di Peace now! mi hanno cacciato dalla manifestazione. Lì ho capito che non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. C’è una differenza fondamentale tra i sionisti di sinistra e chi sionista non vuole essere.
Il momento cruciale per me è stata la guerra del Libano. Nell’ 81, a sedici anni e mezzo, ho lasciato il liceo e mi sono trasferito a Tel Aviv. Avevo cominciato a lavorare con la fotografia, facevo del fotogiornalismo ...
Hai fatto una scuola di fotografia?
No, in realtà l’interesse per la fotografia è più antico. Da ragazzino adoravo la chimica, a casa avevo un laboratorio, mi lanciavo in esperimenti, esplosioni... La fotografia mi dava la possibilità di continuare con la chimica in camera oscura, realizzando in più delle immagini. Mi hanno regalato una macchina fotografica e così è iniziata...
E il fatto che fossimo in piena guerra del Libano, durante uno dei periodi di maggiore attività politica, non era certo indifferente. Per vivere facevo lavoretti qua e là, il barman, il cameriere nei ristoranti. È stato allora che ho incontrato gli esponenti dell’estrema sinistra israeliana. Avevo diciotto anni. Allora accade l’episodio più terribile della guerra in Libano, il massacro di Sabra e Chatila. Sharon segna così la mia adolescenza: è il criminale per eccellenza. Non è mai cambiato, e neppure poteva farlo, continua a essere ciò che rappresentava allora.
L’82 era anche l’anno in cui dovevo entrare nell’esercito, il 17 novembre, sessanta giorni esatti dopo Sabra e Chatila. Già dall’anno prima avevo deciso che non avrei fatto il servizio militare, ho cominciato a cercare ogni mezzo possibile per evitarlo. In Israele ti chiamano la prima volta a sedici anni, non volevo andarci, ne ero sicuro, ma da noi l’obiezione di coscienza non esiste, la sola via d’uscita è farsi credere pazzi. Così ho iniziato a fare il folle, avevo anche molta paura perchè non fare il servizio militare metteva in una situazione difficile. Essere riformati per ragioni psichiatriche impediva di prendere la patente, non si poteva lavorare nell’amministrazione e negli impieghi pubblici. Ma non avevo altra scelta. All’inizio raccontavo che non stavo bene, che avevo problemi familiari ... Ho fatto anche delle prove per entrare nell’unità radiofonica e fotografica, nel giornale dell’esercito. Infine ho deciso di fargli credere che ero omosessuale, l’esercito allora non li voleva ... Interpretavo il ruolo della “Grande Pazza”, avevo messo in piedi tutta una strategia, per un anno sono passato da una commissione medica all’altra, gli facevo intendere che se mi avessero obbligato al servizio militare mi sarei suicidato. Il giorno in cui sarei dovuto salire sull’autobus per raggiungere la mia unità sono tornato dallo psichiatra… Mi ci è voluto un anno ma alla fine ce l’ho fatta, sono stato riformato. Eravamo già nell’83, Israele stava vivendo una crisi economica spaventosa, c’era stato il grande crollo della borsa israeliana, l’inflazione era altissima e la situazione generale molto tesa. Vivevo sempre a Tel Aviv e lavoravo per una società di marketing. Finché nell’85 ho deciso di lasciare Israele per Parigi. Ci ero già stato nell’81 e non ho preso in considerazione nessun’altra possibilità. Avevo un biglietto aperto, non conoscevo nessuno, non sapevo cosa avrei fatto, non parlavo francese però c’erano i ricordi di infanzia, i racconti di mia madre, Sartre, l’esistenzialismo, il quartiere latino… A Parigi viveva qualcuno della famiglia materna, una zia e il figlio della cugina di mia madre, Rony Brauman col quale anni dopo ho girato Uno specialista. Non avevo particolari rapporti con loro, ero senza documenti, vendevo manifesti nel metrò, palloni al Centre Pompidou, abitavo in una stanzetta, andavo avanti con cinque franchi al giorno... A un certo punto ho provato a iscrivermi alla Sorbona, volevo studiare francese e ottenere i documenti necessari per restare. Ma non avevo il diploma e non mi hanno accettato. Sono rimasto lo stesso. Mi avevano preso come guardiano in una galleria fotografica, e a un certo punto, non mi ricordo neanche come e certo con molta arroganza, ho deciso che bisognava trovare un’immagine per “rappresentare” la miseria e il terzo mondo. Mi dicevo che stava a me dare l’esempio e ho iniziato a scrivere un testo teorico, che è poi diventata la sceneggiatura di Aqabat Jaber- Vie de passage (1987). Non avevo mai girato un film prima ma davo l’impressione di saperlo fare e ho trovato un giovane produttore che ha accettato la scommessa. Il primo film, come si sa, è sempre il più facile, le difficoltà arrivano col secondo...
Non avevi mai toccato una macchina da presa o frequentato qualche corso alla scuola del cinema?
No, avevo esperienza di macchine fotografiche e avevo visto moltissimi documentari. Li adoravo. Quando non andavo a scuola mi alzavo e accendevo la tv, che nel frattempo era a arrivata a casa, e guardavo documentari. Erano film sugli animali, di viaggio, antropologici, c’era di tutto e mi piaceva moltissimo. Inoltre volevo viaggiare e pensavo che il documentario fosse un buon modo per farlo. Nell’86 non si poteva fare un film senza l’appoggio di una televisione o di un’altra istituzione. Io avevo bisogno di ventimila dollari, sono andato all’Onu a Vienna e in 48 ore li ho convinti che dovevo girare in un campo di rifugiati…
Era un posto che avevo conosciuto in occasione di un servizio fotografico di moda, ci avevo portato delle modelle... Era magnifico, abbandonato nel deserto… Avevo anche scoperto che ci vivevano delle persone e mi è rimasto in mente. Dieci anni dopo ho pensato di fare un film su di loro, i rifugiati, gente che vive in una situazione precaria ma rifiuta di radicarsi. È per questo che ho intitolato il film Aqabat Jaber - Vie de passage. C’è la vita e c’è la sopravvivenza, che è la condizione più difficile, la vita rappresenta la normalità. Tra le due c’è la “vita di passaggio” che è uno stato provvisorio. Sono riuscito a finire il film l’ultimo giorno prima che chiudessero la selezione di Cinéma du réel, il festival del documentario al Centre Pompidou. La copia non era ancora pronta, ho preso le bobine dal tavolo di montaggio e le ho portate ai selezionatori. Il delegato generale era Marie Christine de Navacelle, nel comitato di selezione c’era Jean Rouch. Mi hanno chiamato qualche giorno dopo dicendomi che ero stato preso, parlavo malissimo francese, eravamo nell’ufficio al Beaubourg di Marie Christine de Navacelle, lei mi faceva un sacco di complimenti mentre Jean Rouch non aveva amato il film. O meglio, disse una cosa del tipo: “Sembra che lo ha girato per avere un premio al Cinéma du réel”. Ho vinto davvero, era il decimo anniversario di quello che allora era il più importante festival del documentario nel mondo, e Vies de passage era il mio primo film. Quell’anno Jean Rouch cominciò a fare il suo Bilan etnographique e lo volle nella sua selezione... Il premio è stato molto importante: in un attimo mi sono trovato invitato a tutti i festival del documentario nel mondo, e ho avuto così la possibilità di fare un incontro politico prima inimmaginabile. Non era ancora iniziata la prima Intifada - il festival era in marzo, l'Intifada è scoppiata in dicembre - e un film sui rifugiati palestinesi era qualcosa di sorprendente. Sono subito venuti a cercarmi gli attivisti pro-paletinesi, quelli anti-occupazione, l’Olp, l’Organizzazione di liberazione della Palestina, e il suo ambasciatore si sono interessati a me... Con l’inizio dell’Intifada mi sono gettato in un’attività politica che andava oltre la militanza, era una scelta di clandestinità. Avevo infatti cominciato a lavorare per l’ufficio israeliano di liberazione della Palestina diretto da Abu Mazen, cosa era assolutamente illegale secondo la legge israeliana. Passare dalla parte del movimento di liberazione palestinese equivaleva a essere considerati terroristi. Solo parlare con qualcuno dell’Olp comportava una condanna a tre anni di prigione. Andavo in giro per Israele con una macchina da presa e facevo interviste a uomini politici israeliani per capire se erano disposti a incontrare rappresentanti dell’Olp. Portavo le cassette a Tunisi, dove si trovava allora la sede dell’Olp, e intanto i palestinesi verificavano le possibilità di dialogo, facevano negoziazioni… A me spettava il compito di documentare, lavoravo in un ufficio che traduceva la stampa israeliana in arabo. In parte è stato questo l’inizio del processo che ha portato qualche anno dopo agli accordi di Oslo. Se lo avessi saputo forse non vi avrei contribuito… Allora però l’esercito sparava nei Territori sui bambini che appendevano alle finestre la bandiera palestinese.
Durante la prima Intifada entravo spesso nei Territori occupati, davamo ai ragazzi delle piccole telecamere insegnandogli a filmare. Sono state le prime immagini che arrivavano dall’interno delle manifestazioni palestinesi, che riprendevano le pietre e l’esercito israeliano...
Le mie posizioni politiche erano diventate ancora più radicali. Viaggiavo, incontravo gente del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, altri del Fronte democratico (nasce nel ’70 da una scissione del Fronte popolare, fondato l’anno prima ndr), dei veri “terroristi”… Nell’88, un anno dopo Aqabat Jaber e in piena Intifada, l’Olp mi ha fatto conoscere i rappresentanti della Lista progressista per la pace, un partito ebreo-arabo guidato da Matti Peled, un anziano generale dell’esercito israeliano. Era un partito nazionalista-arabo ma rappresentava anche il tentativo di formare una federazione dei diversi movimenti antisionisti intorno a un politico israeliano che era stato tra i primi a negoziare con l’Olp. L’incontro era stato fissato in Belgio, o a Vienna non ricordo bene, e visto che era l’Olp a finanziare in buona parte questo partito, sono stati loro a decidere che avrei realizzato gli spot della campagna elettorale. Per questo sono rientrato in Israele.
Avevi realizzato altre cose dopo Aqabat jaber?
Dei film istituzionali, qui in Francia. Dovevo pur vivere di qualcosa.
La campagna elettorale della Lista progressista per la pace è stata quasi totalmente censurata. Solo pochissimi dei nostri spot sono passati in televisione. Le cose in Israele funzionavano così: c’erano degli spazi pubblicitari destinati a ogni partito e noi avevamo a disposizione ventidue minuti, ma la commissione elettorale ci ha bloccati. Per loro mostrare la dichiarazione di Arafat che da Tunisi accettava la risoluzione 242(che chiede il ritiro di Israele dai Territori arabi e palestinesi occupati nel 1967, ndr) era illegale. C’era uno spot che avevamo chiamato Rifiuto di servire l’esercito nei Territori occupati, anche questo era stato vietato, e così Onore all’Intifada, dove l’Intifada veniva definita il regalo più bello che il popolo palestinese aveva fatto a quello israeliano. Alla fine su ventidue minuti ne hanno oscurati undici.
Dicevi che non hai mai fatto degli studi di cinema ma che eri un attento spettatore di documentari…
Non ero quel che si dice un cinephile. Per un certo periodo ho frequentato la Cineteca di Gerusalemme ma sceglievo i film per le tematiche che esprimevano. Mi interessava il cinema sociale.
Immaginiamo che anche le immagini che passavano in televisione avessero una funzione di propaganda…
Quando ero ragazzino c’era un solo canale televisivo in Israele, quello di stato. Non potevamo renderci conto che si trattava di propaganda visto che tutto era propaganda.
Quali registi israeliani conoscevi?
Conoscevo Amos Gitai che, prima di “diventare” Amos Gitai, è stato uno dei migliori documentaristi israeliani. Il suo Journal de campagne dell’82 è stato un film estremamente importante per me. Nel mio primo film ho lavorato con Nurith Aviv, che era stata il direttore della fotografia di Gitai. Quando ho partecipato a quel programma di ragazzini Amos Gitai era già un regista della televisione israeliana. Io ero un piccolo reporter di tredici anni, Gitai ne aveva ventisette, era tornato dagli Stati uniti dove aveva finito gli studi di architettura, e aveva cominciato a lavorare per la televisione girando La casa, un altro film magnifico, una vera lezione di documentarismo politico. Conoscevo anche i film sociali di Ram Levy, il suo film sul 48 era stato censurato dalla tv ma gli altri si riusciva a vederli. Tutto il resto era lo sguardo dello stato.
Quindi il cinema è stata una scelta legata innanzitutto alla militanza politica?
Il mio rapporto con l’arte visiva riguarda più la fotografia, che mi è sempre piaciuta moltissimo. Nell’unica libreria di Gerusalemme che vendeva questo genere di libri compravo tutto quanto riguardava Cartier-Bresson… Non sono arrivato al cinema guidato da un sentimento cinefilo, di imitazione di altri… E mi sentivo distante dalla finzione, la mia cultura cinematografica era molto eclettica ma senza particolari nozioni teoriche. In mente avevo piuttosto la grande fotografia, i grandi fotoreportage… In effetti il cinema comincia a diventare uno strumento espressivo all’interno del lavoro politico. Come dico spesso, è stata una scelta per difetto. Tra le critiche che mi vengono fatte la più ricorrente è che i miei film potrebbero essere dei saggi scritti. In parte è così, ma non la vedo come una cosa negativa, considero il cinema davvero uno strumento. Sul mio tavolo c’era un fotografia dell’inagurazione di Cinecittà. Vi ricordate lo slogan? “Il cinema è l’arma più forte”.
Al tempo stesso però nei tuoi film c’è un costante lavoro di riflessione sull’immagine che è soprattutto smantellamento di luoghi comuni e di archetipi ricorrenti. L’immagine della vittima o la rappresentazione dei nazisti biondi e perversi, quasi una fascinazione, che si ripete nel cinema mondiale dopo la guerra viene ribaltata dalla figura dello “specialista”. E d’altra parte non vediamo mai il conflitto israeliano-palestinese nelle sue rappresentazioni più comunemente utilizzate.
Il cinema per me è immagine, per questo non lo separo dalle altre espressioni visive. Posso dire oggi, a posteriori, che la sceneggiatura di Aqabat Jaber - Vie de passage era essenzialmente un saggio sullo statuto dell’immagine. Volevo girare con due macchine da presa per mostrare anche la troupe al lavoro. C’erano scene in cui provocavo determinate situazioni, ero convinto che si doveva fare anche quello. Però pensavo di essere in un deserto, non sapevo che altri avevano riflettuto da tempo sulla questione prima di me… Ecco perché parlavo di un atteggiamento molto arrogante, anche se perdonabile a un ragazzo di vent’anni. Da tempo ero molto preso dal problema di come rappresentare la fame nel mondo. Non mi interessava mostrare bambini magri con la pancia gonfia, avevo pensato invece a una postazione televisiva in cui si vedevano delle immagini dell’Africa con davanti una famiglia a tavola mentre mangia; stanno lì tranquilli, dicono passami il formaggio, dammi questo o quello… In un progetto d’installazione, per mostrare quanta gente muore di fame nel mondo avevo pensato a una montagna di chicchi di riso. Comunque il punto era sempre la rappresentazione, come tradurre la fame in un’immagine. Pensavo in termini visuali, il mezzo con cui realizzare le mie idee era l’immagine. Come vi sarete accorti non uso mai la parola cinema: è l’universo delle immagini, la fotografia o la fotografia in movimento, che ha un legame molto stretto con la realtà. Aqabat jaber comincia con i rifugiati che dicono: questo tipo vuole fare un film su di noi, porterà le nostre fotografie in America… La prima immagine di Uno Specialista è una sala cinematografica vuota. Volevo che la presenza della macchina da presa fosse evidente, che si dichiarasse “stiamo entrando nel cinema”, non siamo nella sfera della presentazione ma in quella della rappresentazione. Così in Aqabat Jaber quando si vede la donna che lancia una pietra contro la macchina da presa: ci troviamo ugualmente “dentro”, di colpo si rompe l’idea che tutto va bene, che siamo bravi, siamo in campo di rifugiati … Fino alla fine del film dove ci si confronta col senso dell’immagine. Le donne con le polaroid che dicono “dammi la mia immagine” rimandano a una lettura politica e alla riflessione sulla natura delle immagini che attraversa tutti i miei film. Izkor inizia allo stesso modo, ci si chiede: dobbiamo fare questo film? Tutto ciò significa anche domandarsi cosa è il cinema documentario, cosa vuol dire rappresentare la realtà. Uno specialista o uno qualsiasi dei miei film si possono leggere, almeno spero, su due livelli. Uno legato alla tematica e uno ulteriore in cui ci si interroga sulla possibilità di rappresentazione del cinema. Ecco perché i miei corsi universitari cominciano da qui.
Parlando della distizione tra finzione e documentario ripeto sempre che la nostra prima domanda non deve riguardare cosa si mostra ma cosa non si mostra, il punto di partenza sono i quattro mascherini che delimitano l’immagine. La dinamica tra lo spettatore e il cineasta deve basarsi su questa mancanza, lo spettatore deve chiedersi: cosa non mi ha mostrato? Cosa accade al di là delle immagini? Si deve essere consapevoli che quanto si vede sullo schermo è uno spettacolo, con le sue leggi… In uno Uno Specialista spingo ancora più in là la critica a questo meccanismo, affermando che siamo davanti a una mise en scene con elementi di realtà. È la sola distinzione che faccio tra finzione e documentario. Da una parte c’è la messinscena del reale, la finzione, dall’altra la m